•
![]()
C
ARBONERA
E
IL SUO
TERRITORIO:
Indagine Storico Geografico e
Artistica
di
T AFF ARELLO TIZIA NO
Materiale corretto e riordinato da
Gianni
Morandin e Alessandro Pedrina
A CURA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONERA
ANNO 1999
•
![]()
C
ARBONERA
E
IL SUO
TERRITORIO:
Indagine Storico Geografico e
Artistica
di
T AFF ARELLO TIZIA NO
Materiale corretto e riordinato da
Gianni
Morandin e Alessandro Pedrina
A CURA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONERA
ANNO 1999
IL COMUNE DI
CARBONERA
ASPETTO GEOGRAFICO
E CLIMATICO
Carbonera é il primo comune a nord-est di Treviso. Confina con i
comuni di Treviso, Villorba, Spresiano,
Maserada, Breda di Piave e
San Biagio di Callalta. Il comune di Carbonera comprende le seguenti frazioni: Mignagola, Pezzan, San Giacomo di
Musestrelle e Vascon. Il
suo territorio, dalla forma geometrica irregolare, misura K.mq.
19.784 ed é collocato in quella fascia nord-orientale della provincià
di Treviso compresa tra i fiumi Sile e Piave. Il
sottosuolo é costituito prevalentemente da banchi di ghiaia e di
misto alluvionale, provenienti dalle periodiche alluvioni del fiume Piave.
Questo ha avuto e tuttora avrebbe carattere torrentizio. Le alluvioni antiche e
quelle più recenti, con i loro trasporti, diedero dunque origine allo strato di
ghiaia e misto su cui si fonda Carbonera;
inoltre le alluvioni più recenti concorsero a formare lo strato superficiale
agrario di medio impasto di natura misto-argillosa
sabbiosa. Il materasso ghiaioso, di grande potenza e permeabilità, é interessato da
numerose falde acquifere artesiane aventi in genere ottimi requisiti di
potabilità dalle quali la popolazionè del comune trae
l'acqua necessaria agli usi civili e industriali. La giacitura del terreno del
comune di Carbonera é essenzialmente pianeggiante con
differenze di quota, da zona a zona, relativamente piccole. Oltre che dalla
rete dei piccoli corsi d'acqua il comune di Carbonera
é tagliato,
lungo i confini delle proprietà o in corrispondenza dei limiti di coltura, da fossi di raccolta delle acque piovane. Il terreno é
completamente coltivato ed é suddiviso in proprietà o zone di coltura per lo più di
modeste entità. La natura del terreno e la presenza di acqua assicurano la
riuscita a molte colture, oltre a favorire la crescita di piante di alto fusto
lungo i fossati e i corsi d'acqua. Il comune di Carbonera
é percorso
dai fiumi Melma, Piovensan, Rul,
Mignagola, Nerbon, Pulise, Rio Bagnon, Musestre, Musestrelle, Rivo le
Fontane, Rivo Ghirada, Rivo e Scolo
LE STRADE ROMANE
NEL TERRITORIO DI CARBONERA
E' curioso ed interessante
far notare che la linea di fondo dello stemma del nostro Comune ricorda la
grande "via Claudia Augusta Altinate"
tracciata da Altino al Danubio e che attraversava nei
tempi romani (anche se oggi sopravvive appena il ricordo con qualche traccia a Mignagola e Vascon) da sud a nord
l'intero territorio di Carbonera. Quando il Veneto
divenne parte dell' impero romano, furono costruite
nuove strade romane e alcune passavano per il comune di Carbonera.
Susegana e saliva verso il nord "usque
ad flumen Danuvium", fino al fiume Danubio, per un percorse di
Anche
impera~ri ". Servì a precisi scopi militari e politici, ma
la sua importanza andò oltre: servì di transito alle merci e ai traffici,
unendo così popoli e culture, permettendo il progredire della civiltà.
La via Ungaresca passava vicino a Vascon per Catena e Lovadina
verso il passo millenario del Piave, sulle grave di Papadopoli,
e arrivava fino a Codroipo. Rimase in uso fino alla
costruzione napoleonica del Ponte della Priula e
della Pontebbana. Al passo del Palazzon
si ricorda che si incontrarono Alboino, re dei Longobardi, e il Vescovo di
Treviso, Felice; questo incontro risparmiò il saccheggio delle campagne e della
città. La strada romana "Caltrevisana", che
univa a Maserada la strada di Lancenigo
con la celebre Postioma, fu costruita per affrettare
la congiunzione con Oderzo.
CARBONERA
ASPETTO STORICO
RELIGIOSO ANTROPOMORFICO
Il nome "Carbonera" può avere varie origini. Il nome di Carbonera avrebbe origine pre-romana
e significa terra paludosa, torbosa e boscosa. Un
tempo si dicevano "carbonere" certe parti
di fortificazioni di castelli, dove si conservava il carbone per il lavoro dei
fabbri e per le armi che servivano nelle scorrerie o assalti. Qui c'era un
castello che diede il nome ad una regola, con l'appellativo di Carbonera o di "Castel Bemardo" forse da chi lo eresse.
Carbonera potrebbe peraltro derivar~
dalla bruciatura di boschi e legna per far carbone. Infatti
esiste ancora oggi la via Boschi dove sembra ci fossero molte boscaglie.
Inoltre "carbonere" si chiamavano anche i
fossati lungo le mura della città, quindi il nome "Carbonera"
potrebbe ricollegarsi alla vicinanza del paese a Treviso. Il capoluogo del
nostro Comune un tempo comprendeva queste quattro regole o borgate: Carbonera propriamente detta, Bibano,
il Castello e Mignagola (da fiumicello, "minor aquula" che significa filo d'acqua minore, rispetto
agli altri che attraversano Carbonera). Non si hanno
notizie della erezione della vecchia chiesa di Carbonera,
però si sa che fu sempre della "mensa vescovile". Quando San
Prosdocimo venne a predicare a Treviso, la tradizione dice che egli fece
erigere fuori città una chiesa alla Divina Sapienza. Può darsi che l'abbia fatta erigere nel vicino castello di Carbonera. Le notizie su Carbonera
sono scarse, per quanto antiche. Intorno al 1050 visse Drudone
da Carbonera, il cui figlio Bertaldo, Arcidiacono della chiesa trevigiana,
donò estesi beni in Tessera al monastero di San Benedetto di Po Vecchio
(Mantova). Ai possedimenti che i da Carbonera avevano
in Tessera va aggiunto il loro diritto su parte della chiesa di S.Elena in Tessera; questo, con atto datato 30 ottobre
1089, fu da essi donato al monastero di S.Benedetto di Po Vecchio. I possessi della famiglia da Carbonera durarono sino alla fine del xn secolo.
Nell'anno 1115 i frati cluniacensi ebbero in dono il
monastero di S.Giacomo Apostolo di Crespignaga da Bonifacio fu Bemardo, Bortolo fu Carbone e V olputa
da Carbonera. In una pergamena scritta il 21 marzo
1121 "un Oderico da Carbonera" é
sottoscritto quale testimone ad una donazione di terreni fatta da Gisla di Casiero alla chiesa di
Santa Fosca di Treviso. La chiesa di Carbonera faceva
parte della mensa vescovi le e perciò il vescovo aveva donato alcuni fondi ai
canonici. Questo é dimostrato da una bolla di Papa Lucio III che nel 1184
confermò ai canonici di Treviso i privilegi, i diritti e i possedimenti. Il 15
ottobre 1198, con atto del notaio Pellegrino di Padova, Melio
(Emilio), figlio di Alberto da Carbonera, donò a
Giacomo, priore di S.Elena di Tessera, altri beni
presso Carbonera nella località Fratriis
e Castelletto. Nel 1199 era parroco a Carbonera un
certo Bonifacio. Nell'anno 1241 Ezzelino da Romano
prese il castello di Carbonera e lo fortificò. Ma il
21 luglio dello stesso anno i trevigiani se ne
impadronirono facendo prigioniero il presidio tedesco tenutovi dal tiranno,
distruggendo poi il castello. Da allora di quel castello non rimase più nulla,
sembra che esso si trovasse fra il Melma e il Piovensan (tra le case Carraretto
e Dossini). Infatti si dice
che in quel luogo, quando si scavò la ghiaia da portare a Treviso per fare lo
scalo merci ferroviario, vi trovarono resti di armi, grossi tronchi d'albero e
ossa umane. Al castello possedevano terreni e case non solo
i certosini, ma anche i domenicani di S.Nicolò di
Treviso e i Serviti (Servi di Maria del convento S.Caterina
di Treviso). In un documento del 1259 si nomina Jacobus
Ayvardi di Carbonera. Della
vecchia chiesa di Carbonera troviamo cenno solo nel
1217. Essa era filiale della Pieve di S.Maria e San
Giovanni Battista di Piovenzano e Lancenigo
che, a sua volta, faceva parte dell' Arcipretato di Quinto. Gli arcipretati
della diocesi di Treviso erano quattro. La chiesa era dedicata alla Vergine
sotto il titolo dell'Assunta o di
S.Maria Maggiore di Carbonera.
Conservò questo titolo per molti. secoli e anche il
Registro delle messe del 1824-27 é intitolato così: "Registro delle S.Messe che si celebrano nella parrocchiale chiesa di S.Maria Maggiore di Carbonera".
Nell'anno 1598 il titolare della chiesa era il Redentore o
Dopo 60 anni circa
dalla costruzione della chiesa, la facciata del tempio fu completata coprendo i
mattoni con marmorino e rivestendo di
marmo tutta la base. La facciata della chiesa sembra dorata, così appare
quando é illuminata dai raggi solari e inoltre é ornata da
quattro mosaici multicolore raffiguranti il Redentore, S.Pio X, il servo di Dio Mons. Longhin e l'Assunta.
ASPETTO ARTISTICO
La villa Tiepolo, ora
Passi, é una grandiosa costruzione risalente ai primi anni del 1600 con un
bellissimo giardino arricchito di opere scultoree in pietra e un vasto parco
tutto intorno. La casa patronale era un tempo staccata
dalle adiacenze, mentre ora non lo é più. La costruzione aveva un carattere
orizzontale, con la facciata rotta da finestre alte e strette, ad arco, al
primo piano. L'aggiunta dell'abbaino, sproporzionato rispetto al corpo, ha interrotto
la primitiva proporzione facendo perdere alla villa il carattere di linearità e
compattezza voluta dall'ignoto architetto, preoccupato di rendere confortevoli
gli interni con una piacevole distribuzione delle stanze intorno al vasto
salone, a sua volta arricchito da un notevole ciclo di affreschi con finte
architetture e personaggi mitologici. Anche l'autore delle pitture é ignoto, ma
non deve essere stato tm autore di secondo piano,
dato il carattere impetuoso che scaturisce dalle scene e la fantasmagoria dei
colori. Il piccolo tempio é affiancato da un piacevole campanile con cupolino, arricchito con stucchi veneziani, con un affresco
sul soffitto e una pala raffigurante i Santi Domenico
e Gaetano. Alcune statue, che si trovano nel giardino, sono attribuite a
Giuseppe Bemardi detto Torreni
(1694-1774), nella cui bottega lavorò a lungo Antonio Canova.
L'oratorio privato venne eretto nell'anno 1663 per
opera del Com. Alessandro Ermolao Tiepolo,
dopo aver ottenuto il permesso di avere il Santissimo da Papa Alessandro VI,
con indulgenza plenaria. Invece la chiesetta, che si affaccia ora sulla strada,
é stata eretta da un altro Ermolao Alessandro Tiepolo
il 15 luglio 1774, com'é ricordato nella lapide sulla facciata della stessa.
L'oratorio é dedicato al Rosario per ricordare il trionfo na
••.. ale
di Lepanto nel 1571, ritenuto una grazia della Madonna del Rosario. Pio VII vi
ha fatto pure delle roncessioni spirituali.
L'oratorio é provveduto di paramenti sacri. La villa, attualmente della fam.
Passi, fu fatta costruire dal Senatore Almoro Tiepolo, personaggio a proposito del quale Carlo Gozzi racconta un episodio rivolto a dimostrare come nel periodo
di decadenza taluni patrizi "serbas...~ro salde le maschie virtù interiori". Nel 1918 la
villa Tiepolo diventò "Ospedale Militare Croce Rossa-città di Milano n.7".
Nel
La villa Gradenigo, ora
Pellegrini, fu fatta costruire dai conti Gradenigo
nel XV secolo. I Gradenigo, nobili veneziani, erano
benefici villeggianti a Carbonera; alcuni furono
quivi sepolti. Nella villa
MIGNAGOLA
ASPETTO STORICO,
RELIGIOSO E TOPONOMASTICO
L'origine del nome
di questa località deriva dal latino "minor aquula"
(da cui Mignagola) che significa "filo d'acqua
minore", rispetto agli altri fiumi che attraversano Carbonera.
La prima comparsa nella storia di Mignagola come
entità civile avvenne nel Medioevo. Precisamente in un
documento del 1314 ("Quarterium de Ripa
1314"), riguardante le Pievi e le regole dei territori di Treviso, si
nomina la regola di Mignagola che allora apparteneva
alla Pieve di Lancenigo. Inoltre in una relazione del
1345 si accenna alla regola (borgata) di Mignagola
che faceva parte della Zosagna di Sopra. Nel Medioevo
ogni anno si formavano delle commissioni, le quali dovevano recarsi (dopo il
raccolto) nelle varie parti della podesteria e
prendere nota, presso ciascuna famiglia, del quantitativo di produzione di
frumento, segala, avena, legumi, sorgo e miglio. Queste commissioni erano
formate ciascuna da un cittadino, un notaio e un banditore. In tutto erano
otto, quante erano le regioni in cui la podesteria di
Treviso era allora divisa: Campagna di Sopra e Campagna di Sotto, Zosagna di Sopra e Zosagna di
Sotto, Mestrina di Sopra e Mestrina
di Sotto,
e del glorioso S.Giovanni Battista
Protettore di questa Scola e di tutta
Un'interessante
notizia, riguardante lo sviluppo dell'attività della cartiera artigianale di Mignagola, si trova in un certificato della Repubblica di
Venezia. Infatti il 4 febbraio 1764 i Provveditori
sopra i beni inculti della Repubblica di Venezia
concedevano a Giovanni Battista Grenoll'uso di tre
ruote ad uso cartiera sul Mignagola in Carbonera e di commutare due ruote ad uso mulino in uso
cartiera. La cartiera di Mignagola, l'odierna Burgo, fu acquistata da Tommaso Salsa
e dai suoi figli Agostino, Carlo, Antonio e Francesco intorno al 1800. Quando
morì Tommaso Salsa, la cartiera fu gestita dal figlio
Francesco un primo periodo, poi dal fratello Carlo che era medico condotto di Carbonera. Allora la cartiera aveva sei tini e poteva
fabbricare Kg.500/600 di carta al
giorno. Lo smercio della produzione era rivolto verso Trieste e l'Oriente. Nel
1838 la famiglia Antonio Salsa eresse dentro le mura della cartiera, vicino
alla portineria vecchia, un oratorio dedicato alla Madonnà
della Salute affinché proteggesse gli operai della cartiera. Contemporaneamente
questo oratorio era dedicato a
S.Antonio da Padova in ricordo del donatore. L'oratorio era di
bella forma, con coretti laterali al presbiterio, ampio e bene arredato, e
sacrestia dietro l'altare. Questa chiesetta non era pubblica come ci testimonia un documento scritto 1'8 agosto 1902:
"Questa Curia dichiara che
è abbellito da una nicchia dedicata a Maria Bambina con
relativa statua. La base dell'altare, a cui si giunge
salendo tre gradini, é di cemento inciso e decorato. L'altare é di marmo
rosato; sopra di esso spicca una grande croce incavata
in un alto muro. Dietro l'altare, si trova l'organo costruito nel 1927 e
installato nella chiesa nel 1967. Il pavimento é di marmo chiaro al centro
della navata, a riquadri bianchi e rosati sotto le due file di banchi che sono
in legno di noce. All'esterno, davanti alla porta principale, ci sono alcuni
gradini. La chiesa presenta sul lato sinistro un'entrata laterale per la
sacrestia e il tempio, sul lato destro un porticato dove la gente ripone le biciclette quando si reca in chiesa. Nell'ottobre del 1982
(8 otto - 6 nov.), 25° anniversario dell'erezione della nuova parrocchia di Mignagola, il parroco e la comunità del paese hanno voluto
completare il tempio intonacando tutte le pareti esterne, perché i mattoni,
esposti ad intemperie del tempo, si erano deteriorati. Così la generosità e la
pietà dei fedeli hanno dato a Dio una chiesa più splendente e graziosa. Nella
prima metà del XX secolo a Mignagola accaddero alcuni
fatti storici importanti. Nella primavera del 1911 il re Vittorio Emanuele III
venne a Mignagola presso la villa Bussola (sita in via Codalunga) dell'On. senatore
Ubaldo Bussola per una visita. Il re d'Italia, approfittando dell'occasione,
partecipò ad una partita di caccia, con il senatore, nel parco dietro la villa.
Durante le fasi finali della prima guerra mondiale il territorio di Mignagola, come quello del nostro comune, si trovò
vicinissimo al fronte di battaglia. Infatti, dopo la disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917), il comando supremo dell'esercito,
passato dalle mani di Cadorna a quelle del generale Diaz, costituì sul Piave la
nuova linea difensiva che andava dal massiccio del Monte Grappa al Montello e lungo il Piave. Inoltre, il comando supremo
della linea difensiva stabilì di trasformare Villa Bussola in sede del comando
generale del fronte-Piave. Così più volte il generale
Diaz controllò il fronte Grappa-Piave, dalla villa
Bussola. Con la formazione del nuovo fronte, sul territorio di Mignagola passava la terza linea di combattimento. Infatti lungo la via Codalunga e
lungo altri territori erano fissate barriere di filo spinato sostenute da pali
alti due metri; in più, ogni cento metri era installata una pesante
mitragliatrice. Durante la grande guerra, una divisione di soldati era accampata
dietro la cartiera Reali (ora Burgo)
e là, difendendola, sparava verso il fronte. Allora una parte di territorio,
dentro le mura della cartiera, era destinata a base militare di riposo per i
soldati del fronte, ma nonostante queste difficoltà la cartiera continuava a
produrre carta. Mignagola visse il tumultuoso e
confuso periodo della guerra dal 1940 al
ASPETTO ARTISTICO
L'ex villa
Bussola, sita in via
Codalunga, risale alla seconda metà del XVII secolo o
agli inizi del XVIII secolo. Questa villa é stata costruita con mattoni
lavorati, intervallati da qualche giro di sassi, specialmente la parte della
stalla. I soffitti, i solai e i tetti sono in legno con copertura di robuste
tegole. Allora si usava il legno per queste strutture poiché é un materiale
molto malleabile; infatti i soffitti erano decorati e
lavorati. Il pavimento é in maiolica veneziana, un prodotto tipicamente
italiano. Le piastrelle sono ricoperte di smalto opaco. I balconi della casa
sono piccoli e numerosi per praticità e collocati in più direzioni nella
stanza. Per rafforzare gli angoli della casa i costruttori di questa villa si
sono serviti di ferri a forma di X come ancoraggi primitivi. Al primo piano
erano situate le camere da letto e un ampio granaio. Nella cucina esisteva il
caminetto a pianta centrale che serviva per cuocere il cibo e riscaldare la
stanza. Questo caminetto era simbolo di unità familiare e portava un'unione più
intima delle persone. Tipici e funzionali erano i portici con un'arcata che
servivano a tutti gli usi: come atrio spazioso per la casa, per riparo, per
l'accesso alle varie stanze, come deposito di attrezzi e come luogo di lavoro.
Dall'interno partiva la grande scala in legno decorato
che dava accesso alle stanze del piano superiore. Un tempo questa villa era
circondata da un bellissimo giardino ricco di fiori e da un
vasto parco verde ora trasformato in terreno coltivabile. Nella
primavera del 1911 questa villa, del senatore Bussola, ricevette la visita del
re d'Italia Vittorio Emanuele m. Durante la prima guerra
mondiale la villa fu trasformata in una base militare e comando generale del
fronte Piave. Poi nel 1927 Villa Bussola, avente valore artistico, fu venduta
come casa colonica alla famiglia Taffarello Fiorino.
Ora é stata oggetto di adattamenti e trasformazioni,
ma l'architettura moderna conserva le originali caratteristiche.
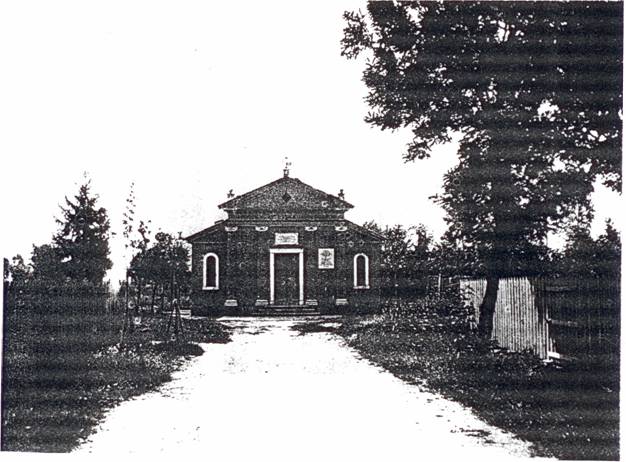
|
'-
58.
Questa chicJCllo .HHgCl'll
alla .lini! di
un viale di tigli ed ip/)(JCtlSfllfli, do\'c ora .\'j Irorll ilj1orcl1cggio BI/I)!,O, di./ì·oJl!e
alla portineria lUI l'cl. {i, erella /lcl 1'113 riai
('(I Il (e Gill.H'flfIC Volfli c dClIlolfla lIegli IlJ/lli Ci//IfI/III1/a
l'N .1(,1' Iwslo a/ Essa era SIa lO CIIslruiw il/ sosliluziol/c di quella che si Il"01'111'0 a/f'il/INI/O dc/lo slabifill/Cl/w, l'rcsm {'alli/aie cill/il/icra c che l'm SIO/a volula da TOlI/lI/a,H! Salsa I/cl 1838, |
~ •..
,~.'.
__ o
PEZZAN
ASPETTO STORICO,
RELIGIOSO E TOPONOMASTICO
Il nome di questa località deriva da
pezze di terreno dissodate e ridotte all'agricoltura lungo il fiume Melma. Le
prime date storiche di Pezzan risalgono al XIV
secolo. In questo periodo i patroni di Collalto diedero
la chiesa di Pezzan, ultima cappella di Lancenigo, al monastero di Nervesa.
Questo fatto é nominato nella bolla di Gregorio IX (1231) che riconobbe la
cappella esistente a Pezzano e di essa
dicevasi: "della Pieve di Lancenigo
soggetta alla Giurisdizione dell'Ill.mo. R.R.Monsignore conte di Collalto
dell'abbazia di Nervesa". Nel 1356, quando i Veneziani
erano minacciati di guerra dal potentissimo re d'Ungheria Ludovico, prima che
Treviso fosse assediata, fu demolito il castello dei Pezzani
per un decreto ducale del 1356, emesso dal Doge Giovanni Gradinigo;
diceva fra l'altro: " ..... fu esso castello
demolito e furono riempite le fosse nel timore che al nemico servir potesse di
qualche difesa". Riguardo a questo episodio qualcuno pensa che Pezzan abbia preso il nome dai "Pezzani",
una nobile famiglia che possedeva vasti territori e il castello lungo il fiume
Melma sulla via Ungaresca
(sec. XII). A detta famiglia succedette
La fabbricazione
della carta a Pezzan risale all'epoca della sua
invenzione. Testimonianza della plurisecolare attività delle cartiere in questo
paese é un documento del 1683 dove sta scritto che un
direttore di cartiera ha pagato il testatico anche per i suoi
operai. Questa notizia avvalora l'antichità delle cartiere di Pezzan. Presso questa località esistevano tre cartiere: due
lungo il Melma e una lungo il fiume Bagnon. La cartiera Venerando, gestita poi dalla S.p.a. Cartiera di Carbonera, é
stata fondata nel 1814, ma già sul luogo esisteva una primitiva cartiera
artigianale. All'inizio era stata costruita per fabbricare carta-paglia
lavorata a mano e asciugata all' aria. Ancora oggi non
si conosce il nome del suo fondatore, ma da molti anni era in proprietà della
fam. Venerando. Nel
ASPETTO
ARTISTICO
Lungo la riva
sinistra del Melma si trova Villa Maria (ex
Villa Lebreton) con ampio parco e campo da calcio.
Nella storia di Pezzan ricorre più volte il nome dei
signori Gradenigo e si pensa che la nobile famiglia
veneziana abbia fatto costruire questa villa verso la metà del 1600, sul luogo
dove un tempo sorgeva il castello dei "Pezzani".
Lo stile veneziano della villa si può notare nella facciata e soprattutto negli
affreschi della sala di entrata. La cappella, posta esternamente con sub-titolo
"Charitatis", reca in alto la scritta: Ave
Maria. Detto oratorio era noto in passato come dei Gaggio,
dei dal Maschio, dei Lebreton,
e questo dovrebbe essere il succedersi dei vari proprietari prima che la villa
diventasse un istituto per il recupero e il reinserimento dei minorenni, con l'
ausilio dei padri maristi. L'attuale villa Brusso, ex villa Santina e villa Veneta, era in origine
un monastero e luogo di villeggiatura degli Eremitani o frati Agostiniani di
Treviso. Questi furono i fondatori della Scuola o Confraternita della
"Madonna della Cintura" nel 1596. Agli Eremitani succedettero i
Filippini (religiosi oratori ani di Venezia) che vi abitarono fino al 1860.
Della prima costruzione, risalente al 1500, rimane l'ala dell'attuale villa che
porta lo stemma con cappello doganale. Un bel parco, l'ex "vigna o
brolo" dei frati, abbellisce e circonda la villa mentre
davanti a questa si trova la "cappella della Visitazione". La villa
si trova alla confluenza delle due strade che, scendendo da due cavalcavia
sull'autostrada alemagna A 27, conducono da Pezzan a Breda di Piave.
Dell'attuale casa
Torresan, in via Graere, non si sa con certezza lo scopo della costruzione.
Tuttavia si suppone che in origine fosse abitata da religiosi; inoltre questa
ipotesi é stata avvalorata dal ricordo della gente di un oratorio presso questa
villa. La villa Torresan, che risale al 1600, prima
degli attuali proprietari era in mano ai signori Facco
da Genova. Questa casa di valore artistico fu sede del municipio di Pezzano nel periodo di governo austriaco. Infatti, prima
che il comune di Carbonera iniziasse la sua attività
ufficialmente (1 maggio 1816), l'odierno territorio era diviso in quattro
comuni diversi tra loro. Così la sede del comune di Pezzan
era in casa Torresan, e il signor Giuseppe Miceletto, ricco proprietario di terre, esercitò le
funzioni di sindaco e segretario durante il governo austriaco.
SAN GIACOMO DI MUSESTRELLE
ASPETTO STORICO, RELIGIOSO E TOPONOMASTICO
Il paese viene
distinto e preceduto dal nome del Santo Patrono S.Giacomo
Maggiore aggiungendovi il termine della località Musestrelle,
piccolo fiume che l'attraversa. Secondo alcuni la fondazione di questo paese é
dovuta a quei monaci Benedettini che furono a capo dei nuclei fuggiaschi che,
qua e là, diedero origine alle località con il toponimo di persona, in questo
caso di Santo. Quelle comunità di cristiani, con a
capo religiosi, scelsero per il loro paese quel santo che maggiormente veniva
onorato. Il titolo S.Giacomo Maggiore allude alla
fondazione della chiesa, per i pellegrini di Compostella,
come luogo di preghiera, di riposo e di ristoro. Inoltre, essendo dipinti nella
pala del pittore udinese Amaretto i santi Giacomo e
Cristoforo (invocato contro le alluvioni e i danni provocati dalle acque) le
cui festività cadono nel medesimo giorno 25 luglio, si potrebbe altresì
riconoscere l'istituzione della chiesa quale voto per sfuggire agli infortuni,
specialmente alle alluvioni. I primi cenni storici di questo paese risalgono al
XIV secolo. Infatti nel 1314 S.Giacomo
di M. faceva parte integrante, con altre regole, della Pieve madre di Varago. La prima comparsa nella storia del paese come
entità civile, awenne nel
chiesa. Nel 1601
il reddito della chiesa era di 70 misure di frumento d'affitto e 5 della villa
(ossia secondo il testatico), 7 botti di vino oltre quello del paese, 2 misure
di spelta, un carro di fieno più 15 ducati di
contratti d'affitto di case. La chiesa di S.Giacomo
di M. venne eretta, ex novo, sullo stesso luogo della
precedente intorno all'anno 1662, mentre il coro venne costruito nell'anno
1751. La torre campanaria, preesistente alla nuova chiesa, subì degli
ammodernamenti con delle riparazioni nello stesso periodo. Nel 1752 fu
trasportato da Venezia l'altare maggiore in marmo, al tempo in cui era parroco G.M.Sartorio, che ne fece donazione alla chiesa di S.Giacomo. Sugli altari laterali ci sono due pale di autore
ignoto: una rappresentante "
ASPETTO
ARTISTICO
La villa Pasina, con la
sua semplice costruzione a pianta rettangolare, riflette la caratteristica
architettura veneziana del XVI secolo. II vasto parco, disseminato di alberi
giganteschi con una certa simmetria, le dà un tono solenne ed elegante. Il
cancello principale é ornato dallo stemma gentilizio che ci avverte della nobile
abitazione. Un documento certifica la proprietà dei nobili da Lese, almeno dal
1540; prima di questa data non si ha notizia dei primi proprietari. Nella
seconda metà del secolo scorso il mulino con l'abitazione annessa fu acquistato
da N.H. Ottone Pasini, patrizio padovano, e poi dato
in gestione e in eredità al figlio Giovanni Ottone. Allora la proprietà
comprendeva
Casa ex-villa
Moretti, quando venne
costruita nel XVII secolo, assunse caratteristiche e nome di vera villa, nome
che conservò dopo l'aggiunta fatta posteriormente all'ala destra, con i
porticati tipici delle case coloniche, venendo adibita ad abitazione di diverse
famiglie contadine e abbandonata dal suo ricco proprietario. Nel 1720, questa
villa era di proprietà del nobile Ruzzini ed in essa trovarono alloggio le famiglie degli Zanzoletto Nadal e fratello
Domenico, Anzolo Tabachin e
Leonardo, Bernardo Saramani.
Le ultime famiglie che l'ebbero come abitazione furono quelle dei Pianta, Zanotto, Piaser, Dalla Lana e Bianchin,
che poi si sistemarono con proprie abitazioni. Durante la guerra 1915-18, servì
da punto di riferimento nelle carte topografiche militari,
come "villa Moretti". Attualmente la villa
Moretti, proprietà dei conti Persico, giace nel più completo abbandono.
L'attuale casa
Moro, sita vicino alla chiesa, fu costruita nel XVI secolo. Essa presenta
una sagomatura stretta e bislunga (con delle marcate aggiunte) per i balconi
non lineari e, specialmente specialmente
per quelle inferriate, simili a spioncini e rilevabili solo nelle costruzioni
claustrali. Dalle anzi dette strutture si desume pertanto che, nell'intento dei suoi costruttori, sia servita dal principio
come vero e proprio monastero o convento di religiose, dipendenti dall'abbazia
di S.Daniel
di Venezia. Ciò spiega anche la vicinanza della casa
Moro alla chiesa di S.Giacomo di M. Questo
ex-convento risale al XVI secolo come le altre case degli affittuari, che
provvedevano con l'affitto a mantenere sia il monastero che la stessa abbazia
madre. E' certamente una delle più antiche case del paese che, malgrado le ristrutturazioni e le aggiunte subite nel tempo,
conserva la sua particolare sagomatura architettonica, propria di quel lontano
tempo e relativa ad un convento.
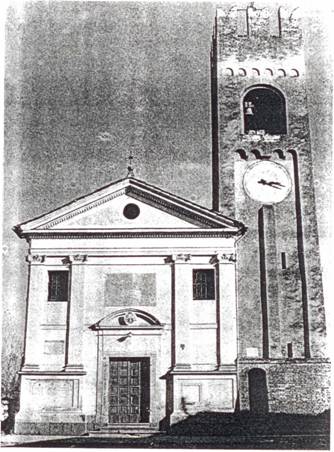
Come ci viene presentata da
una fotografia scattata nel
V ASCON
ASPETTO STORICO,
RELIGIOSO E TOPONOMASTICO
Il nome "Vascon"
può avere varie origini. Vascon può derivare da
"vasca" per le acque raccoltevi, o da waso,
d'onde vassallo, o da Guascone essendo "gu" uguale alla "v" nei primi documenti.
Così sarebbe stato un signore della Guascogna, al tempo dei Franchi, il
possessore e abitatore del castello o palazzo di Vascon,
che diede vocabolo al paese. Si ricordano infatti nel
1153 Bertrando e poi Orlando (nomi Franchi) di Vascon,
i quali tenevano qua i beni di Gisla da Casier e, nel 1189, Orlando investì il capitolo del
Castello e delle fratte al prezzo di f. 238 malgrado si
opponesse suo fratello. Poi nel 1225 il giudice Dario di Vascon
fu testimone quando in S.Martino
di Lupari per il B.Giovanni
da Schio vennero appianate le contese dei comuni della marca trevigiana. Padrone della chiesa, prima filiale di Lancenigo, é sempre stato il Vescovo che ne fece una
prebenda rappresentata nel quaderno della decima con fIO, con 25 ducati nel 1474, con f500 nel 1790 per il
testatico sostituito ai quartesi, onde nel 1448 da
ogni famiglia si ricevevano 1/4 di frumento, un secchio di vino, una misura di
varie biade e le botti degli affitti. Ma nel 1790 il governo doveva aggiungere
quanto mancasse alla somma di 100 ducati d'oro
considerati valore minimo per ogni beneficio del parroco. Il titolo di S.Lucia Y.M.,
che predisse la fine della persecuzione e per il nome s'intese patrona della
vista, può risalire a quando ne fu portato il corpo a Venezia. Nel 1488 fu
ordinata la pala dell'altar maggiore per adempire ad un testamento e fu anche
rinnovata nel 1621. Gli altri due altari furono eretti con i vocaboli del
Crocefisso e del Rosario. Si ricorda che nel 1506 con temerario ordine furono
deposti i battagli delle campane e, nel 1520, con il beneficio, fu donata una
casa colonica, alla quale nel 1726 il parroco Barlese
aggiungeva la casetta per il cappellano. Le croci scoperte nelle pareti, anno
1699, provano l'antica consacrazione della chiesa. Nello stesso anno si
rifabbricavano questo tempio sacro e le sue statue dei S.S.Battista
e Sebastiano che decoravano l'altar maggiore. Agli inizi del
Con
grande impegno e sacrificio da parte dei vasconesi,
il 24 agosto 1930 fu inaugurato il nuovo campanile alto
ASPETTO
ARTISTICO
La costruzione
della villa Valier Loredan,
ora Perocco, risale alla seconda metà del 1600. Con
la chiara struttura seicentesca dell'edificio contrasta troppo apertamente
perché non debba venire considerata un'aggiunta del
periodo neoclassico, la parte centrale della facciata costituita da quattro
colonne ioniche al primo piano, sorgenti dal bugnato sotto stante, che
inquadrano tre fori ad arco con poggioli. Un timpano, con finestrella
circolare, conclude, a livello del terzo piano, questa sovrapposizione che così
finisce per turbare eccessivamente la severa compostezza del fabbricato. Anche
i collegamenti tra l'abitazione e le due piacevoli barchesse
laterali potrebbero essere successivi. All'interno della villa si conserva uno
splendido ciclo di affreschi attribuiti un tempo ad Antonio Bellucci
ed ora ritenuti del veneziano Nicolò Bambini (1657-1736). Il salone affrescato
presenta da un lato il "Ratto delle Sabine" e dall'
altro due episodi dell 'Eneide: Enea, che
riceve le armi divine, e la morte di Turno. Altri due affreschi di dimensioni
minori si trovano sempre nel salone e raffigurano Apollo e Flora. In questo
ciclo il Bambini, se di lui si tratta, ha lasciato una
delle migliori testimonianze della sua attività pittorica per l'armonia del
colore, il realismo dell'impianto architettonico e la serenità del paesaggio.
La villa, ora in proprietà dei Perocco di Meduna, é meravigliosamente conservata, bianca e luminosa,
in uno scenario verde e lussureggiante.
La villa dei
signori veneziani Tivinelli, ex colonia agricola e ora sede della cooperativa
"Alternativa", risale ai primi anni del 1700. Il suo oratorio
dell'Annunziata, detto di Castelcucco (nome questo
derivante dall'antico castello), risulta essere il più antico della parrocchia
di Vascon. Infatti il
vescovo Fortunato Morosini ricorda nel 1717 che non
ci sono nel paese chiese campestri se non quella del Tivinelli.
Il nobile Angelo Tivinelli era allora il proprietario
della villa e del fondo. Nel 1758 proprietario era il sig. Bertoldo Fiori e mansionario don Girolamo Battistella.
L'otto ottobre 1778 si legge nella relazione della visita
pastorale: "Oratorio pubblico del sig. Francesco Domenico Manenti, mercante veneziano, sotto il titolo
dell'Annunziata, nel comune di Vascon. Altare tutto
di marmo senza croci nell'antipetto con pala dove si vede dipinto l'Arcangelo
Gabriele in atto di recare il felice annunzio a Maria V., di sotto una monaca.
Visitò esso altare fornito di tutto punto e ordinò la croce nell'antipetto
dell'altare. Visitò dietro l'altare la sacrestia, dove andò ogni cosa a dovere.
Si ha l'obbligo di tre messe la settimana, le quali si celebrano di qui innanzi
da un sacerdote già stabilito per mansionario: non vi
ha né reliquie né indulgenze. Manca la croce sul tetto". Un'osservazione
critica su questo oratorio può far pensare a tutto il mondo religioso di un
tempo. Il fondo e la villa passarono alla ditta Callegari
prof. Francesco del fu Pietro il 20/10/1826. Nel 1841
nasceva a Venezia Giuseppe Callegari (1841-1906) che,
fattosi prete, veniva qui a Vascon
dalla zia Marianna Callegari a passare le vacanze.
Giuseppe Callegari é diventato poi vescovo di Treviso
nel 1880 e ha avuto come collaboratore Giuseppe Sarto, poi papa Pio X, che nel
1903 lo fece cardinale. Queste "presenze di
amicizia" divennero anche per Vascon persone
familiari; infatti tutti vissero con cuore e partecipazione
i loro momenti religiosi nella chiesetta. Nel 1867 il vescovo Federico Zinelli scrive della "Pala del Tiepolo
-di buona forma-", é certamente la
pittura precedentemente descritta. Nel cambio di proprietà é facile che sia
stata asportata dai proprietari oppure, come testimonia qualche
paesano, sia andata in rovina per l'abbandono in soffitta. Nel 1908
risulta proprietario della villa e del fondo Mons.
Olivo Luisetto, ma già nel 1923 si dice in proprietà del sig. Ettore Zanatta. In precedenza l'oratorio subì un ampliamento nella
parte del presbiterio e dell'altare. Nel giorno 14 gennaio 1924 il vescovo A.G.Longhin venne in visita pastorale presso questo
oratorio. Nel settembre 1931 é sorta
grande benefattore Cav. Ernesto Dartora (da Onigo 1858-1939) come si ricorda in una lapide all'interno della villa. I nuovi gestori furono i Padri Giuseppini e direttore il Padre Giovanni Dario; essi gestivano le scuole professionali provinciali, prima che passassero a Lancenigo, per ben 30 anni. Poi l'oratorio e la villa caddero in abbandono, dopo che la villa fu ridotta al primo piano, si dice, per pericolosità e le sue statue furono vendute alle ville vicine per mantenere in vita l'opera. Ora con l'arrivo della nuova Cooperativa "Alternativa" é ripresa la vita nella villa. L'oratorio dell' Annunziata, squallido e depauperato, risvegliò nei vicini l'antica fede e vitalità per cui riebbe in breve tempo la sua bellezza e dignità.
La villa Caccianiga, in via Antonio Caccianiga (poeta) risale ai primi del 1700, infatti la semplice ma troneggiante costruzione a pianta rettangolare rispecchia le strutture geometriche tipiche dell' architettura di quel periodo. Questa villa fu costruita sulle rovine di un monastero di monaci, e difatti, qualche anno fa, sradicando alcune piante del parco, vennero alla luce un pezzo di mura, grandi sassi, mattoni; inoltre, la tradizione dice che le colonne presenti in garage sono quelle del chiostro. Questo monastero, eretto prima del Mille, dipendeva da quello di Monastier; per di più si dice che da codesto convento un sotterraneo portava direttamente alla chiesa della Madonna della neve a Varago. I primi proprietari della villa furono i nobili veneziani Gradenigo che poi l'hanno venduta al sig. Ernesto Caccianiga agli inizi del secolo scorso. Un tempo la villa possedeva una cappella privata interna il cui altare (in stile barocco), dedicato alla Beata Maria Vergine, fu gentilmente donato alla chiesa di Vascon, ora però non esiste perché é andato distrutto. All'interno la villa é ornata con stucchi alla veneziana e con varie decorazioni. Il collegamento tra l'abitazione e il piacevole porticato é successivo alla costruzione del fabbricato dominicale, infatti sono due edifici con strutture architettoniche diverse. Ora la villa é splendidamente conservata in un meraviglioso parco.
Zoldan, ex-villa della contessa Monterumigi, in stile veneziano, risale alla prima metà del Settecento e fu restaurata nel 1857. Questa villa fu comperata dalla fam. Zoldan nel 1922. I pavimenti sono di tipo veneziano mentre il poggiolo é costituito da marmo d'Istria. Un tempo era circondata da un bellissimo giardino arricchito da opere scultoree in pietra (ora vendute) e da un vasto parco ormai trasformato in terreno coltivabile.
La villa Bragadin, ora Ruberti, fu costruita agli inizi del Settecento.
ASPETTO
TOPONOMASTICO E
L'usanza che fino a pochi anni orsono creava una vera e propria confusione nella nostra società, specie rurale, era quella di affibbiare alle famiglie dei nomignoli e vari soprannomi, per distinguere lo stesso cognome o per mettere in evidenza caratteristiche somatiche, fisiche, sociali o personali del capo famiglia, come per esempio: Fini cei, Fini grandi, Stentarelli, Pagnocconi, Castrini. Così avveniva che nei nostri paesi il vero nome delle famiglie scompariva, per restare solo negli atti anagrafico-amministrativi e nella corrispondenza. Un tempo, un portalettere che non fosse del luogo, prima di orientarsi nella distribuzione della posta, doveva faticare molto, non solo perché inesperto, ma anche perché i compaesani non conoscevano il vero cognome del destinatario. Come si sa l'uso dei soprannomi ha dato origine ai nostri cognomi. Presso i Romani il cognome era il nome di famiglia originato per lo più dal soprannome, mentre il praenomen era il nome di persona ed il nomen era il nome della gens, gruppo di famiglia derivante da un medesimo stipite. Durante il basso impero i soprannomi sovrabbondarono, creando così un vero caos durante le invasioni barbariche. Ma dopo il Mille cominciò a radicarsi in Italia ed in altri paesi civili l'uso di designare le famiglie soltanto con i soprannomi dei capofamiglia; soprannomi nati per designazione popolare da qualche particolarità fisica o morale, buona o cattiva, così si ebbero i Forti, i Bassi, i Baldi, i Calvi, oppure dalla professione esercitata come i Barbieri, i Ferrai, i Sarti, i Marangoni .... , oppure derivanti dai nomi delle terre o di città d'origine come i Visentin, i Padovan, i Trevisan, i Romagnol.... Nei secoli
successivi, l'uso dei cognomi, così fonnulati,
si generalizzò e si disciplinò, finché fu consacrato nei
censimenti, costituendo con i nomi propri di persona un sistema perfetto di
identificazione delle famiglie e dei singoli cittadini. Questa identificazione
però riguarda solo atti anagrafi ci ed ufficiali,
perché la pessima abitudine di appellare e di distinguere le famiglie, il più
delle volte, con un difetto riflettente una parte fisica o morale del
capofamiglia, nel senso vero e proprio dispregiativo, durerà fino ai nostri
giorni. Infatti una volta molte delle nostre famiglie
avevano due cognomi, e di solito venivano chiamate col secondo e ancora adesso
si continua così nel gergo popolare. Per esempio, nel nostro comune, Fava detto
Faon, Cenedese detto Bagnol, Piovesan detto Bastianello, Dotto detto Biso, De
Tuoni detto Pevariol, Mattiuzzo
detto Cibi n, Beni detto Baron, Andreuzza
detto Isotto, Marchi detto Teso, Gasparinotto detto Boscariol, Cescon detto Corona, Pavanello detto Bicchio, Minello
detto Teoro, Girotto detto Biraeto ..... Oggi il fattore
progresso, rivoluzionando tutti i settori della nostra vita, ha inferto un colpo
mortale anche a questa usanza. Così le nuove generazioni, per un'etica e per
una più completa educazione sociale, si conoscono esclusivamente per nome e
cognome. Inoltre i frequenti spostamenti da un paese all'altro e le soventi
immigrazioni fanno sì che il nuovo arrivato venga
conosciuto con il suo vero cognome e che i poco graditi epiteti e nomignoli
siano lasciati nel vecchio paese di provenienza. E' questo un fatto positivo
per le nostre campagne e per una convivenza più rispettosa, più educata e più
consona ai tempi attuali.
ASPETTO SOCIALE
Insieme con altri
molteplici fattori, anche l'edilizia ha contribuito ad allontanare gli
agricoltori dalla terra. Il bracciantato ha sostituito fittavoli e mezzadri.
Molti contadini con la buonuscita si sono costruiti la casa ed hanno avuto un
po' di terreno. Ovviamente é morto anche tutto il piccolo artigianato che
viveva come ausiliario di quel tipo di agricoltura fatta a forza di braccia e
animali. Oggi é scomparsa la figura della vecchia famiglia agricola, chiusa in
se stessa, refrattaria a novità, avulsa dall'istruzione ... etc. Soltanto i
padri e i nonni fanno i contadini, mentre i figli maschi e femmine frequentano
le scuole, lavorano in fabbrica o hanno altri impieghi. Oggi i cittadini del
nostro Comune sono occupati in tutte le arti e in tutte le professioni. Dagli
anni Settanta in poi, la maggior parte della gioventù non si fenna dopo le medie inferiori, ma
continua gli studi nelle medie superiori e all'università. Così le nostre
famiglie possiamo chiamarle "composite", perché i membri esercitano
varie attività; pertanto in casa si parla di vari argomenti: di politica, di
religione, di scuola, di cultura, di sport .....
Allora é evidente che, con l'abbandono
graduale della terra, con l'immigrazione delle famiglie provenienti da ogni
parte e da ogni categoria sociale, con l'evasione dalla casa propria, si é trasfonnato il clima sociale e religioso del comune di Carbonera.
ASPETTO
EDILIZIO-URBANISTICO
Le frazioni del
comune di Carbonera hanno avuto negli ultimi anni un
forte sviluppo e ingrandimento, con un costante aumento della popolazione. Così
a Carbonera, soprattutto negli anni 1971-
dà un aspetto più urbano al paese, si nota maggionnente nel capoluogo Carbonera,
a Biban e Mignagola.
ASPETTO CULTURALE
Anche nel comune di Carbonera
nacquero o vissero personaggi storici importanti dal punto di vista culturale.
TENTORI DON
CRISTOFORO era nato a Venezia nel 1738 da una famiglia oriunda di Camposanpiero, ed intraprese la professione di letterato.
Egli fu ospite di casa Tiepolo a Carbonera. E' autore delle seguenti opere: "Della
legislazione Veneta sulla Preservazione della Laguna" é una dissertazione storico-filosofico-critica
(Edizione Venezia 1792); "Raccolta cronologica ragionata di documenti
inediti" che fonnano la storia diplomatica della
Rivoluzione e caduta della Repubblica di Venezia, corredata da critiche
osservazioni (Edizione Augusta 1799). Infine scrisse "Il vero carattere
politico di Baiamonte Tiepolo"
e un "Saggio sulla Storia degli Stati della Repubblica di Venezia". Tentori don Cristoforo, ex-gesuita spagnolo, morì il 2
ottobre 1&10 a Carbonera all'età di 72 anni e
venne sepolto nel cimitero del paese.
JACOPO BORTOLAN di
Carbonera (1785-1842) é famoso per aver introdotto, per primo in Italia, il
rame in lastre sottili. Inoltre é importante ricordarlo perché per primo aprì a
Treviso le scuole elementari e divenne ispettore scolastico sotto il governo
austriaco.
MORETTO AUGUSTO
era un capo muratore, ma anche studioso. Mentre era obbligato a rimanere a
letto per una lunga malattia polmonare, scrisse con qualche pregio un romanzo
storico nel 1881 dal titolo: "Gilda, o l'assedio di Treviso"
illustrando le memorie del castello di Carbonera.
Morì il 19 dicembre 1 &&
l all'età di 2& anni.
SINTESI CRONOLOGICA
DEL COMUNE DI CARBONERA
1307 -
Nella Pieve di Lancenigo: regole di Carbonera, Castello di Carbonera,
Vasco e Bibano.
Nella Pieve di Varago:
regole di Musestrelle e di S.Giacomo.
1744 -
Nella Zosagna di Sopra: Villa di Carbonera,
Castello di Carbonera, Pezzan,
Mignagola,
Vascon, S.Giacomo di Musestrelle.
1807 - Nel distretto e cantone di Treviso: comuni di Pezzan, Carbonera e Vascon.
1 & 15 - In comune di Treviso
1/5/1816 - Comune di Carbonera (fondazione).
N.B. Fino a
qualche decennio addietro ebbe pieno valore la secolare divisione del
territorio trevigiano che contrapponeva la città
murata alla campagna circostante ed alle "frazioni". Dal nome delle
chiese del territorio circostante si erano denominati fin dal primo Medioevo i
nuovi centri abitati "Cappella" prima "Parrocchia" poi
nell'ordinamento ecclesiastico, "Regole" in quello del Comune
Medioevale, "Villa delle cerchie" nel periodo Veneziano. Tali
località gli austriaci dissero "azioni" nome che passò poi
nell'ordinamento italiano. Attualmente vige la distinzione
legale tra "frazioni geografiche" e "frazioni
amministrative", entità territoriali le une e le altre con particolari;
effetti; successe nel diritto positivo, in sostituzione delle frazioni note
puramente come entità tradizionali e storiche.
FONTI: AA.VV.